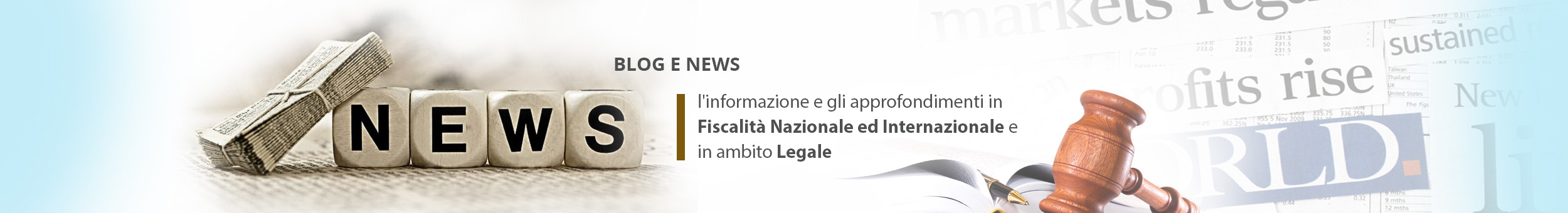Sfide e opportunità nell'attuazione del Modello 231
A cura del Dott. Maksym Kovach, partecipante all’Executive Master in Giurista d’Impresa
Il decreto legislativo1 8 giugno 2001, n.231 segna l’abbandono del principio secondo cui societas delinquere non potest e introduce – anche nell’ordinamento italiano – la corporate crime liability,al fine di fronteggiare efficacemente la criminalità delle imprese, colpendo le condotte illecite commesse al loro interno. In altre parole, con il d.lgs. 231/2001 viene introdotta la responsabilità amministrativa dell’ente collettivo2, per i reati commessi3 (c.d. reati-presupposto), nel suo interesse o vantaggio, da parte di persone fisiche appartenenti al medesimo.
Secondo la Corte di Cassazione4 “si tratta di tertium genus di responsabilità nascente dall’ibridazione della responsabilità amministrativa con i principi e concetti propri della sfera penale”. La particolarità di questa disciplina risiede nel fatto che:
- la responsabilità posta a carico dell’ente, ancorché dipendente dalla commissione di un reato,si presenta come autonoma (art. 8) vale a dire, aggiuntiva e non sostitutiva di quella di persone fisiche5. Infatti, se risulta accertata la commissione di un reato l’ente, ne dovrà rispondere sul piano amministrativo, anche nel caso in cui non è stato possibile ascrivere la responsabilità penale in capo a un determinato soggetto;
- ricade sull’ente-imputato il compito di dimostrare6 – per essere esentato dalla responsabilità – una serie di requisiti cumulativi ex art. 6 (c.d. inversione dell’onere della prova);
- l’accertamento dell’illecito è effettuato con il rito penale ma la responsabilità resta amministrativa e non penale di conseguenza, l’eventuale sanzione amministrativa nei confronti dell’ente è irrogata dal giudice penale e non dalla pubblica amministrazione come normalmente accade.
La Suprema Corte7 ha specificato che “il significato letterale, sistematico e finalistico dell’articolo 8 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 è nel senso non tanto dell’autonomia dell’illecito amministrativo a carico dell’ente e dell’illecito penale relativo al reato presupposto (giacché, anzi,l’illecito amministrativo “presuppone” e, quindi, dipende da quello penale), quanto piuttosto dell’autonomia delle due condanne sotto il profilo processuale. Per la responsabilità amministrativa è necessario che venga compiuto un reato da parte del soggetto riconducibile all’ente, ma non è anche necessario che tale reato venga accertato con individuazione e condanna del responsabile: la responsabilità penale presupposta può essere ritenuta solo incidenter tantum (ad esempio perché non si è potuto individuare il responsabile o perché questi non è imputabile) e ciò nonostante può essere sanzionata in via amministrativa la società”.
In origine il d.lgs. 231/2001 prevedeva come reati, dal cui verificarsi dipende il sorgere della responsabilità dell’ente, solamente alcuni delitti dolosi, successivamente a questi sono stati aggiuntianche i reati colposi8 (previsti dagli artt. 589 e 590 c.p.), i reati ambientali9 e le contravvenzioni. Nel 2019 e 2022 sono stati inseriti rispettivamente i reati tributari e i delitti contro il patrimonio culturale.
I destinatari del decreto sono gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica (art. 1 comma 2). Le norme del decreto inoltre, si applicano agli enti pubblici economici10, alle società unipersonali e alle società sottoposte alla liquidazione giudiziale11. Le norme non si applicano invece, allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici, nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
L’ente è responsabile per i reati12 commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti13 in posizione apicale o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale. Nella prima categoria rientrano le persone fisiche che esercitato:
Nella seconda categoria rientrano principalmente i prestatori di lavoro subordinato di cui agli artt. 2094 e 2095 c.c., ma anche i lavoratori parasubordinati (ad es. i collaboratori occasionali) e i lavoratori esterni.
La Suprema Corte14 ha precisato che “i criteri ascrittivi della responsabilità da reato degli enti,rappresentati dal riferimento contenuto nell’art. 5 “all’interesse o al vantaggio”, evocano concetti distinti e devono essere intesi come criteri concorrenti, ma comunque alternativi, in quanto il richiamo all’interesse dell’ente valorizza una prospettiva soggettiva della condotta delittuosa posta in essere dalla persona fisica da apprezzare ex ante, mentre il riferimento al vantaggio evidenzia un dato oggettivo che richiede sempre una verifica ex post”.
Ciò significa che la condotta illecita dell’autore materiale del reato deve essere oggetto:
- di una verifica ex ante allo scopo di accertare se la persona fisica abbia agito nell’interessedella società, pur non avendo determinato alcun vantaggio a favore di essa;
- di una verifica ex post allo scopo di accertare se la persona fisica (che abbia o meno agito nell’interesse della società) abbia procurato un vantaggio (anche istantaneo, non permanente) a favore della stessa, attraverso la propria condotta.
In capo all’ente, invece, non sorge alcuna responsabilità quando la persona fisica autore materiale del reato ha agito nell’interesse “esclusivo” proprio o di terzi (art. 5 comma 2). E ciò anche se essa avesse casualmente tratto un vantaggio dalla condotta illecita. Se invece l’autore del reato ha commesso il fatto nel “prevalente” (e quindi, non esclusivo) interesse proprio o di terzi e, l’ente non ne ha ricavato alcun vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo, la sanzione è ridotta.
Il decreto nulla dispone in ordine alla disciplina dei gruppi societari. A tal riguardo, merita di essere menzionata una delle pronunce della Corte di Cassazione15 secondo cui “qualora il reato presupposto sia stato commesso da una società facente parte un gruppo o di una aggregazione di imprese, la responsabilità può estendersi alle società collegate solo a condizione che all’interesse o vantaggio di una società si accompagni anche quello concorrente di altra società e la persona fisica autrice del reato presupposto sia in possesso della qualifica necessaria, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001, ai fini della comune imputazione dell’illecito amministrativo da reato”.
Affinché l’ente sia sanzionabile non è sufficiente un collegamento oggettivo tra la persona fisica e la persona giuridica, né che il reato sia stato posto in essere nell’interesse o a vantaggio dell’ente,occorre altresì dimostrare la c.d. “colpa di organizzazione” consistente nella mancata adozione ovvero nel carente funzionamento del modello preventivo.
A tal fine il legislatore ha diversificato i criteri di attribuzione soggettiva della responsabilità a seconda della categoria di appartenenza degli autori individuali. Nel caso di soggetti apicali l’art. 6 prevede infatti una forma di esonero dalla responsabilità qualora l’ente dimostri che:
- l’organo dirigente ha adoperato ed efficacemente messo in pratica, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a evitare la realizzazione degli illeciti penali in oggetto;
- è stato affidato, a un organo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull’efficace osservanza del modello in questione,nonché di curarne l’aggiornamento;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito fraudolentemente;
- non vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte dell’organismo di vigilanza.
Diversamente, nell’ipotesi di reato commesso da un soggetto sottoposto all’altrui direzione o vigilanza, l’esclusione della responsabilità dell’ente – determinata dalla preventiva adozione ed efficace attuazione del modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi – è considerata un elemento di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità della società e la quale, non deve dimostrare che sia stata realizzata da parte dell’autore dell’illecito una condotta fraudolente elusiva delle prescrizioni contenute all’interno del Modello, come invece accade nel caso in cui il reato è stato commesso da uno dei soggetti che si trova in posizione apicale.
L’adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo da parte dell’ente è facoltativa, e non costituisce un obbligo giuridico. In alcuni casi, però, la sua adozione è richiesta (e quindi, risulta di fatto obbligatoria):
- ai fini dell’attribuzione del rating di legalità;
- ai fini dell’ottenimento della qualifica di STAR da parte delle società quotate;
- se previsto dalle normative regionali, nel caso in cui l’azienda intende intrattenere i rapporti con la pubblica amministrazione.
Inoltre, gli amministratori che non abbiano adottato un idoneo modello organizzativo, sono da ritenersi civilmente responsabili nei confronti della società nel caso in cui l’ente sia stato condannato ex d.lgs 231/2001.
Tralasciando il metodo da seguire per predisporre concretamente il Modello in parola, e focalizzando l’attenzione sulle finalità e sul contenuto dello stesso (così come è previsto dall’art. 6 comma 2 e comma 2-bis), la sua elaborazione comporta una pianificazione del lavoro che, in genere, prevede le seguenti fasi:
- Analisi conoscitiva della società (ad esempio, tipologia, dimensione, attività, storia ecc.);
- Identificazione delle aree più esposte al rischio di commissione dei reati-presupposto (c.d. mappatura del rischio), vale a dire l’individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati. Ogni società, infatti, presenta i suoi specifici ambiti di rischiosità che variano sia in base al settore economico e all’area geografica in cui opera, sia in base alla sua struttura organizzativa e alle sue dimensioni. Infine, è necessario valutare le modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati previsti dal decreto, in modo da poter adottare le misure preventive idonee a ridurre il rischio reato;
- Eventuale predisposizione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire. L’obiettivo di questa fase è quello di rilevare i sistemi di controllo e procedure esistenti o da implementare, a difesa dei rischi identificati nelle aree “sensibili” individuate nella fase precedente;
- Individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati. Ciò significa che la società deve separare e rendere indipendente il ruolo di chi autorizza l’impiego della risorsa finanziaria, di chi lo attiva e di chi lo controlla.Inoltre, i flussi finanziari devono ispirarsi ai canoni della verificabilità, trasparenza e pertinenza all’attività aziendale;
- Previsione degli obblighi di informazione, soprattutto da parte dei responsabili delle aree a rischio, nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, il quale deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- Previsione di uno o più canali che consentono ai soggetti in posizione apicale e ai loro sottoposti, di presentare a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del decreto (c.d. whistleblowing);
- Introduzione di un sistema disciplinare idoneo, sia a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, sia a tutelare il segnalante;
- Predisposizione del modello;
- Approvazione del modello da parte dell’organo dirigente.
Infine, benché non esplicitamente previsti dalla legge e al fine di rendere il modello più efficace, l’azienda dovrebbe:
- adottare un codice etico, cioè un documento ufficiale che annovera l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell’azienda nei confronti degli stakeholder;
- assicurarsi che il contenuto del modello e altri strumenti siano portati a conoscenza del personale, ad esempio attraverso l’adozione di un apposito programma di formazione.
Il modello di organizzazione, gestione e controllo rappresenta lo strumento per programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in funzione dei reati da prevenire. La programmazione comporta una valutazione del sistema esistente all’interno dell’ente e il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di ridurre16 ad un livello accettabile i rischi identificati. La sua complessità è direttamente proporzionale alle esigenze, alla struttura, alla collocazione geografico-ambientale e alle risorse della singola impresa; variano, inoltre, i singoli reati che, per ipotesi, sono collegabili alle attività dell'ente considerato a rischio.
In definitiva, sebbene il modello di organizzazione rappresenti un onere organizzativo ed economico di cui la società si fa carico – anche perché richiede un costante aggiornamento per adattarsi alle mutevoli esigenze della realtà aziendale – ciò nonostante, si tratta di uno strumento che consente a determinate condizioni, escludere la responsabilità in capo alla societas per illeciti amministrativi dipendenti da reato o quanto meno, attenuare le conseguenze sanzionatorie, migliorare la reputazione dell’impresa e accrescere la sua competitività sui mercati.
Bibliografia:
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
N. Mazzacuva – E. Amati, Diritto penale dell'economia, CEDAM, Wolters Kluwer, 2018
A. Toppan – L. Tosi, Lineamenti di diritto penale dell’impresa, A. Toppan, L. Tosi, CEDAM, Wolters Kluwer, 2017
A. Presutti – A. Bernasconi, Manuale della responsabilità degli enti, Giuffrè, 2018
Tags: BlogLegal